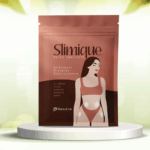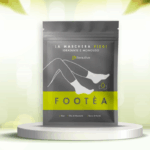Nella coltivazione della vite uno degli aspetti più delicati riguarda la protezione dalle minacce invisibili che si annidano tra le foglie, i grappoli e la corteccia delle piante. Da sempre, il “ladro” responsabile di danni anche ingenti alle viti è costituito da una vasta gamma di insetti e parassiti capaci di compromettere sia la quantità che la qualità della produzione di uva. Questi organismi non solo si nutrono della pianta, ma possono anche veicolare malattie, causando problemi a lungo termine nei vigneti.
I parassiti più insidiosi che attaccano la vite
Quando si pensa a un insetto che depreda silenziosamente la vite, bisogna distinguere tra le diverse specie che agiscono in vari periodi dell’anno e in vari modi.
Uno dei più noti è la Tignoletta della vite (Lobesia botrana), una falena le cui larve attaccano direttamente i grappoli d’uva, scavati dall’interno mentre si sviluppano. Questo insetto depone le uova sulla superficie dei fiori o dei giovani frutti; una volta schiuse, le larve penetrano negli acini nutrendosi della polpa e facilitando l’insorgenza di muffe e marciumi. Il danno avviene spesso senza che ci si accorga subito della sua presenza poiché le larve restano nascoste all’interno degli acini, protette dagli agenti atmosferici e dagli sguardi superficiali.
Un altro protagonista temuto è la cosiddetta cicalina della vite (Empoasca vitis), che attraverso il suo apparato boccale pungente-succhiante, preleva attivamente la linfa vegetale e riduce la capacità della pianta di eseguire la fotosintesi. Questo comporta una evidente riduzione della produttività, ingiallimenti fogliari e in casi estremi la morte della pianta. Le cicaline si riconoscono per il rapido e saltellante movimento sul lato inferiore delle foglie, dove spesso depositano anche le uova.
Altri insetti degni di nota sono:
Modalità di attacco: come operano i veri “ladri” della vite
Gli insetti che infestano la vite sono spesso predatori nascosti. Le larve della Tignoletta vivono protette negli acini o all’interno di nidi sericei costruiti tra i grappoli, e la loro presenza viene rivelata solo da grappoli avvizziti o imbruniti, spesso già compromessi da marciumi secondari. Le cicaline invece agiscono all’aperto, saltando tra una foglia e l’altra e pungendo ripetutamente i tessuti vegetali per assorbirne la linfa vitale.
L’azione di nutrimento di questi parassiti produce vissuti ingiallimenti fogliari, caduta anticipata delle foglie, rachitismo dei grappoli e un generale stress fisiologico della pianta. Il danno maggiore però spesso non è quello visibile: numerosi di questi insetti fungono infatti da vettori di fitoplasmi, agenti patogeni responsabili di malattie a lenta evoluzione come la flavescenza dorata e il legno nero.
Prevenzione e strategie di difesa biologica
La lotta agli insetti della vite, soprattutto nelle realtà agricole più attente alla sostenibilità, si basa su una combinazione integrata di:
In viticoltura professionale è estremamente diffuso il ricorso all’osservazione diretta delle foglie e dei grappoli, intervenendo tempestivamente in caso di presenza di uova o larve. La tignoletta della vite, ad esempio, può essere controllata con l’applicazione di feromoni per confusione sessuale che impediscono l’accoppiamento degli adulti e riducono la nascita di nuove generazioni. Per le cicaline e altri insetti succhiatori, l’utilizzo di oli minerali o vegetali può aiutare a soffocare le uova deposte nei tessuti fogliari.
Un’arma efficace ma da utilizzare con prudenza rimane l’insetticida, preferibilmente a basso impatto ambientale come i prodotti a base di Bacillus thuringiensis, consentiti anche in agricoltura biologica.
L’importanza della prevenzione e del controllo continuo
Il primo passo per difendere le proprie piante dal “ladro” nascosto è adottare una costante azione di prevenzione e monitoraggio. Tra i suggerimenti più efficaci vi sono:
L’attenzione anche ai più piccoli segnali, come foglie con macchie clorotiche, grappoli che iniziano a marcire in modo anomalo o la presenza di piccoli fori negli acini, permette di individuare tempestivamente la presenza di insetti dannosi ed evitare danni gravi e diffusi.
Nel contesto della diffusione globale di nuovi parassiti, fra cui la Popillia japonica, è fondamentale aggiornarsi costantemente sulle innovazioni legislative, tecniche e agronomiche relative alla difesa della vite.
Infine, un vigneto sano e produttivo nasce dall’attenzione quotidiana e dalla conoscenza delle minacce che si nascondono tra i filari. Combattere il “ladro” invisibile richiede un approccio integrato, basato su esperienza, tecnologia e rispetto della natura, per continuare a ottenere uve di alta qualità e garantire la vitalità del vigneto anche nelle annate più sfidanti.